È il 18 dicembre 1893 quando Maria Fischmann diventa dottoressa in Medicina: è la prima donna nell’ateneo dell’Università di Pisa a laurearsi. “Come possono star bene le donne […] che a causa della loro posizione sociale […] si trovano in uno stato agitato […] che si vestono contro tutte le leggi fisiologiche, che si nutrono male”: così scriveva Fischermann nella sua tesi di laurea, parlando di quella che oggi definiremmo medicina di genere.
“La salute delle donne” (2026, Edizioni ETS, 170 pagine) è il titolo del libro della sociologa della salute Rita Biancheri, docente all’Università di Pisa. E Maria Fischermann è uno dei primi nomi che vengono in mente quando, come oggi, 11 febbraio, si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza.
La medicina “tuttora fatica a guardare dove non si è mai rivolto lo sguardo”, come scrive Biancheri: ancora oggi i costrutti del patriarcato e del positivismo sono talmente radicati nella nostra società da risultare invisibili, e di conseguenza difficili da superare. Per quanto gli studi di genere, soprattutto dagli anni Novanta in poi, siano stati in grado di abbattere certe barriere, la resistenza, nel campo medico e al di fuori di esso, è ancora molta.
In occasione della Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza, abbiamo intervistato Rita Biancheri.

Come chiarisce fin dalle prime pagine del libro, la questione del trattamento della salute femminile è indissolubilmente legata all’idea sociale che si ha della donna. Ed è altrettanto chiaro che, per quanto i gender studies abbiano aiutato nell’apertura verso una nuova lettura del femminile, ci siano ancora dei costrutti sociali che, quasi per abitudine e inerzia, come lei stessa precisa, non aiutano a discostarsi da certi preconcetti.
Pensa che la strada intrapresa sia giusta o che ci sia da costruire di nuovo dalle fondamenta?
«Penso che si debba proseguire su questa strada, importante, che si è intrapresa. I gender studies sono stati introdotti con grande difficoltà, soprattutto nelle aree delle scienze cosiddette dure. La scienza è stata fondata sulla cittadinanza, il diritto, la sociologia: quasi tutte le discipline con una centralità di pseudo neutralità e oggettività: in medicina questo pesa ancora molto».
«Ci terrei intanto a ribadire, in occasione di questa Giornata, quanto il contributo che le donne hanno portato alla ricerca sia stato significativo. Quando si parla di gender studies spesso si parla anche di ideologia gender, ma non è la stessa cosa: c’è una grande confusione su questo. Gli studi di genere nelle università, in diverse discipline, da quelle umanistiche a quelle delle aree STEM, hanno aiutato a decostruire il concetto del neutro maschile inclusivo».
«Si deve continuare a sottolineare l’importanza di prospettive diverse, soprattutto in un ambito come quello della medicina, dove l’iperspecializzazione rischia di oscurare ciò che invece dovrebbe essere fondamentale. Virginia Woolf diceva che le donne “vedono lo stesso mondo con occhi diversi”: le donne hanno aiutato a leggere la realtà che ci circonda in modo diverso. Non è un caso che i gender studies siano stati introdotti proprio nel momento in cui le donne sono entrate nelle cosiddette “cittadelle del sapere” e hanno cominciato a vedere quanto questo maschile inclusivo, da cui partiva la costruzione della scienza, avesse cancellato la prospettiva femminile e la soggettività delle donne. Il metodo, di matrice positivista, di cancellare le differenze ha in realtà contribuito a irrigidire le disuguaglianze: non considerare le differenze tra uomo e donna ha fatto sì che queste diventassero disuguaglianze».
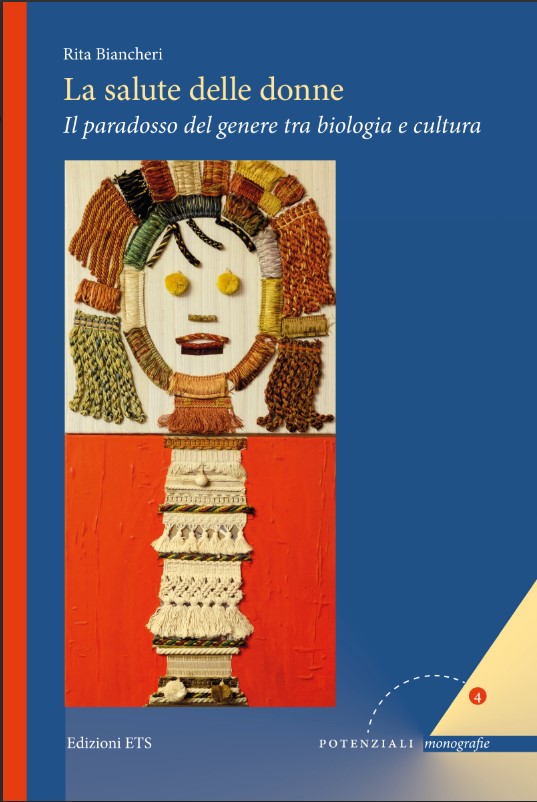
Qual è la novità di approccio della medicina di genere?
«La medicina di genere è un approccio che, invece, considera queste differenze. Le donne sono state doppiamente escluse dalla scienza: prima come studiose, poi come soggetti. E questo perché, come scriveva Simone de Beauvoir, le donne sono considerate il “secondo sesso”, cioè l’Altro rispetto al neutro maschile inclusivo».
«I medici non sono abituati a considerare nell’anamnesi altro rispetto ai fattori biologici. Questa credenza ha portato per lungo tempo a non considerare in medicina altri aspetti, che invece incidono molto sulla salute delle persone: la malattia non è solo un fatto tecnico, ma è anche un fatto biografico ed esistenziale. Un famoso epidemiologo, Marmont, ha detto che le speranze di vita, a Londra, si rilevano dalla fermata della metropolitana: più lontano abiti dal centro e minori sono le speranze di vita».
«Le condizioni socio-economiche e lavorative sono determinanti sociali della malattia. Se dobbiamo tenere presente questo sociale, ed è proprio questa la riflessione che faccio nel mio libro, dobbiamo in qualche modo elaborare una teoria, un approccio che necessita di multidisciplinarietà. Non a caso sempre di più a Medicina si parla di Medical Humanities».
In che modo il paradosso di genere incide attivamente sulla salute delle donne?
«Un esempio concreto è quello che deriva dalla ricerca sulle sperimentazioni dei farmaci, farmaci, dai più generici ai più specifici, che sono testati prevalentemente sugli uomini. Ci sono varie ragioni per le quali le donne partecipano meno ai trial clinici, per esempio la gravidanza e le difficoltà ormonali. Ma questa non partecipazione contribuisce a incrementare gli effetti negativi sulla salute delle donne, in quanto i farmaci non testati sul corpo femminile possono portare ad effetti collaterali. E questo avviene anche per le linee guida sulla salute».
«Uno degli esempi più importanti è quello dell’infarto: la sintomatologia comunemente diffusa per riconoscerlo è quella del dolore al braccio sinistro, ma questo è un sintomo maschile. Questa disinformazione ha spesso comportato una diagnosi ritardata dell’infarto femminile, proprio perché i sintomi sono diversi».
«Nell’ottobre 2025 è uscito un report, a livello mondiale, sull’equità in salute e sui determinanti sociali. Per la prima volta si è parlato non più di stili di vita (quindi fumo, alcol, attenzione all’alimentazione), ma anche di condizioni che riguardano il quotidiano femminile».
Ci descrive la sua ricerca?
«La mia ricerca era partita proprio da questo: io e il mio gruppo abbiamo lavorato sull’applicazione della legge n. 81 del 2008 a Pisa, in dialogo con i medici del lavoro, sulla salute e sicurezza, e abbiamo proprio costituito un gruppo multidisciplinare che tenesse conto di tutti gli aspetti che incidono sulla salute. Abbiamo provato a fare un tipo di anamnesi diversa, aggiungendo alla cartella clinica lo stress e il lavoro, che è uno degli elementi che più incide sulla conciliazione dei tempi di vita. Abbiamo aggiunto il fatto di avere figli, la disponibilità dei servizi e la condivisione del lavoro di cura nella famiglia, visto che spesso sono le donne i caregiver».
«Il fatto che le donne abbiano un grosso carico familiare, asimmetrico rispetto ai compagni, ricade sulla loro salute. Questa doppia presenza, che è un concetto che viene introdotto proprio negli studi di genere, incide sull’insoddisfazione, sulla fragilità delle donne dal punto di vista emotivo».
Un autentico paradosso?
«Infatti il sottotitolo del mio libro è “Il paradosso del genere tra biologia e cultura”. Le donne vivono più a lungo ma con una maggiore morbilità: è un paradosso? Oppure non abbiamo ancora elaborato in maniera più sofisticata le differenze che ci sono dal punto di vista anatomico, ormonale, di genere, tutto quello che è biomedico e che si aggiunge alle condizioni di vita, e quanto queste incidono sulla salute delle donne? Questo elemento richiede ovviamente ascolto, non un’aziendalizzazione della cura. Sappiamo che ci sono tempi molto limitati per le visite mediche, però è una contraddizione, sia dal punto di vista legislativo, sia per il consenso informato, che dice esplicitamente che l’ascolto è tempo di cura. Spesso il consenso informato è ridotto a un atto burocratico, invece di essere una relazione di fiducia che si instaura tra medico e paziente».
«Le donne che soffrono di malattie come la vulvodinia, l’endometriosi e la fibromialgia denunciano la difficoltà ad essere ascoltate dal punto di vista del dolore che manifestano, perché non c’è una collocazione in un organo specifico. Se oggi ci sono più diagnosi di queste malattie è grazie agli studi di genere, al contributo che le donne hanno dato alla scienza. Non è una scienza diversa, semplicemente ha aperto degli scenari diversi, nel continuo progresso che la scienza deve avere nel riconoscere sia la sensibilità dei propri metodi di ricerca, sia gli esiti di queste ricerche».
Quanto pensa che sia difficile far entrare la multidisciplinarietà in ambito medico?
«Io insegno Genere e salute a Medicina, e trovo un grande riscontro tra i miei colleghi sull’argomento. In passato, però, c’è stata anche molta resistenza: la medicina è una scienza ancora positivista, fondata sulla divisione tra mente e corpo. Io ho avuto molta difficoltà anche a parlare con i colleghi, gli amici, anche in famiglia. E ancora oggi, nonostante i sempre maggiori riscontri positivi, ci sono grandi difficoltà a introdurre la materia».
«La visione della donna, la subordinazione, la gerarchia che la donna occupa nella società, si riflette anche nella sua invisibilità: si chiama ingiustizia epistemica. Le medical humanities hanno un posto ancora molto marginale purtroppo, e quindi penso che sia compito di noi docenti invitare a fare questo tipo di contaminazione tra saperi, proprio per evitare di ridurre la complessità di un tema come quello della salute».
«D’altronde tutte le grandi scoperte scientifiche vengono dalla contaminazione tra i saperi: bisogna invitare a questo sguardo critico anche gli studenti. Oliver Sacks disse che a un certo punto aveva sentito il bisogno di uscire dalla sua disciplina, perché c’era soltanto un come della malattia e non un come della persona: dovremmo fare e insegnare lo stesso. Ed è proprio ciò che cerco di coniugare nel mio libro, come sociologa della salute: mettere insieme il mio punto di vista con quello di medici e mediche. In medicina ci deve essere il contributo dell’antropologia, della sociologia, della psicologia, tutte le diverse discipline che servono a spiegare quali sono i fattori sociali e psicologici che devono entrare nella diagnosi e nel percorso terapeutico».
E ad oggi quanta resistenza continua a trovare?
«Un po’ di resistenza c’è. Alle difficoltà dell’innovazione si aggiunge anche l’esigenza dei crediti universitari, perché il curriculum deve essere formato da un certo numero di crediti, dai quali non si può sforare. Si possono fare delle integrazioni, però poi ognuno vuole mantenere i propri crediti e l’importanza della propria materia. Io ho faticato moltissimo, fatico ancora, a integrare in modo congruo le Medical Humanities al percorso di studi. Abbiamo proposto dei cicli di film per sensibilizzare all’empatia, a questo rapporto medico paziente. In Francia, ad esempio, si fa molto teatro per i medici. Si utilizza spesso anche la letteratura: penso a libri come “La coscienza di Zeno”, ma ce ne sono molti che spiegano bene la sofferenza del paziente, quindi che preparano i futuri medici e future mediche all’attenzione alla sofferenza del malato, oltre alla cura».
Segui le nostre news sul canale WhatsApp
CLICCA QUI
Per continuare a rimanere sempre aggiornato
Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici
Quanto ancora c’è bisogno di divulgare cos’è la medicina di genere al pubblico?
«Penso che l’opinione pubblica sia molto importante, e deve estendersi oltre ai medici e ai professionisti sanitari. Tra l’altro la divulgazione è anche nella Terza missione dell’università, per formare e sostenere le scoperte scientifiche nell’opinione pubblica. Io penso che ci sia estremamente bisogno di divulgazione, anche perché tutto questo può e deve essere una richiesta che il paziente stesso, il cittadino, la cittadina, fa al sistema sanitario».
A che punto siamo in Italia? Ci sono paesi più avanti a riguardo?
«Innanzitutto è importante puntualizzare che l’Italia è abbastanza all’avanguardia per quanto riguarda la medicina di genere: siamo l’unico paese in Europa ad aver adottato una legge sulla medicina di genere, nel 2018. È però altrettanto vero che, per la maggior parte, questa legge risulta inapplicata».
«In Europa sono stati proposti molti progetti atti a scambiare buone prassi all’interno di questa disciplina medica. Per esempio in Francia, nonostante non abbiano una legge a riguardo, hanno una maggiore attenzione al rapporto di fiducia medico-paziente. Per quanto anche da noi questa non sia completamente trascurata, penso a quando c’è stato il Covid e a quanto sarebbe stato importante avere una relazione di fiducia con i medici, invece di tutte le fake news che sono girate».
«In Italia abbiamo veramente difficoltà a cambiare, siamo molto rigidi nei cambiamenti. Poi, purtroppo, si cambiano di nuovo e improvvisamente le leggi: c’è adesso una nuova proposta di legge per la medicina di genere, ma riparte da zero. Cambiare sempre significa ripartire dall’inizio, e vanificare gli sforzi precedenti».
«Nelle Università ci sono meno risorse, meno possibilità di sviluppare una formazione adeguata: ora crescono anche le università private, per non parlare della questione del numero chiuso a Medicina, che è un altro problema importante. Lo spazio per cambiare e riflettere è molto difficile da trovare nella routine di un quotidiano così complesso come quello medico, ed è ancora più difficile se le risorse diminuiscono. Se facciamo la legge e poi non troviamo il modo per cambiare il modello culturale su cui la stessa legge insiste, questa rimarrà solo sulla carta».
«Spero che la Regione Toscana, che ha da tanto una legge sulla cittadinanza di genere, possa fare questo salto di qualità, perché dobbiamo trovare degli strumenti semplici per poter applicare la medicina di genere».
Quali pensa che debbano essere i prossimi passi concreti per applicare una giusta ed efficace medicina di genere?
«Il primo passo è la formazione. La formazione è fondamentale, di conseguenza il ruolo delle Università. Vedo che quando poi i giovani frequentano il corso acquisiscono sempre più questa sensibilità. Alla formazione, universitaria e professionale, si aggiungono un’anamnesi e una cartella clinica “nuove”. Basterebbe aggiungere uno spazio apposito nelle cartelle elettroniche che i medici devono compilare per ogni paziente. Questa in particolare sarà una proposta che farò all’assemblea che ci sarà in Regione sul tema della sanità. Si tratterebbe di uno spazio dove segnalare le condizioni di vita del paziente, che sensibilizzi sulla loro importanza tra le informazioni che servono per l’anamnesi».
«In poche parole la medicina deve tornare ad avere un approccio alla persona, e non solo al corpo. Abbiamo ridotto il ruolo della mente, ci siamo limitati a guardare solo il corpo, perché è oggettivo e osservabile. In inglese si utilizzano due termini distinti: disease è la malattia, mentre illness è la percezione della malattia. Il medico deve tenere conto anche della percezione, quindi della percezione sulla propria salute che ha il paziente. Esistevano i medici umanisti, questo prima che la medicina diventasse così specializzata. Il medico ascoltava la storia del paziente. Si tratterebbe di ripercorrere e di riprendere questa sensibilità umanistica, ricordandosi che la medicina è una scienza umana, non una scienza dura».








